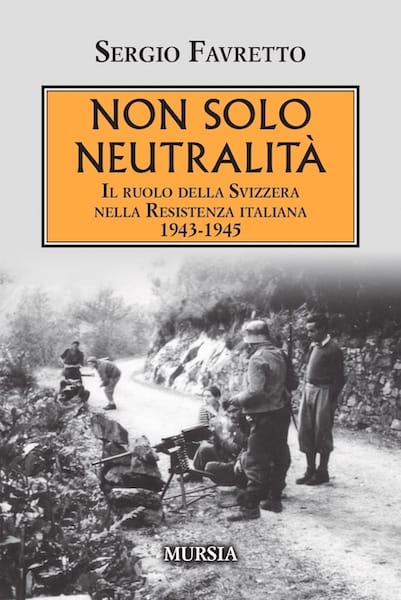Neutralità? La Svizzera nella resistenza italiana
Il ruolo della Svizzera nella Resistenza italiana tra il 1943 e il 1945. Le dinamiche e le azioni che hanno interessato il Paese elvetico durante la seconda guerra mondiale. Sono i temi del nuovo libro di Sergio Favretto (apprezzato collaboratore di Allonsanfan.it), storico e avvocato, intitolato Non solo neutralità. Il ruolo della Svizzera nella Resistenza italiana 1943-1945, nelle librerie per l’editore Ugo Mursia dal 10 novembre.
Sergio, un altro tassello di un lavoro molto ampio e complesso…
«È una ricerca storica che completa un impegno che coltivo da anni: analizzare il fenomeno della Resistenza, a più voci e con differenti contributi, lungo i confini italo-francese, italo-svizzero e a Nord-Est dell’Italia. Le formazioni partigiane, la popolazione a sostegno della lotta di Liberazione, le collaborazioni con le missioni alleate del SOE, che organizzava operazioni clandestine nei territori occupati dai tedeschi, e dell’OSS, uno dei servizi segreti Usa, il soccorso coraggioso per nascondere e poi aiutare a fuggire gli ebrei, sono tutti temi che ho ricostruito in Una trama sottile del 2017, in Con la Resistenza del 2019, in Partigiani del mare del 2023. Lo scorso settembre a Cordenons, in un convegno, ho presentato una ricerca sul rapporto tra cattolici ed ebrei e sulla Resistenza locale nella bufera nazifascista lungo il confine Nord-Est e il Friuli. Ora questo nuovo volume su quanto accadde in Svizzera».
Il volume esce per l’editore Mursia
«Sono contento che Ugo Mursia abbia scelto di editare questo lavoro, inserendolo in una collana di storia e testimonianze. Non solo neutralità è un ampio saggio di indagine storica, nutrito da molti documenti, immagini, testimonianze e ricordi, contributi tratti da diari e archivi. Un mosaico di tessere policrome e rappresentative di un periodo difficile e non sempre ben interpretato».
Qual è stato il ruolo della Svizzera, Paese che si è sempre dichiarato neutrale?
«Negli anni 1943-1945, in pieno scontro bellico, anche la Svizzera ha ricoperto un ruolo cruciale: accanto alla neutralità istituzionale della Confederazione Elvetica, i Cantoni a sud, con militari e Guardie di Frontiera insieme a un’ampia parte della popolazione, hanno fornito un supporto utilissimo alla lotta contro il nazifascismo. Il confine italo-svizzero divenne un passaggio essenziale per migliaia di persone fra ex prigionieri alleati, soldati italiani, antifascisti, giovani renitenti alla leva, partigiani, perseguitati politici ed ebrei in fuga. In Svizzera trovarono ospitalità, soccorso, formazione, cultura e speranza sociale, alimento per la lotta di Liberazione.
Da molte fonti si ricava come la Svizzera è stata anche un importante centro di organizzazione politica per gli esuli antifascisti e un crocevia strategico per i servizi segreti alleati OSS e SOE. Da Berna, Ginevra, Zurigo, Lugano, Bellinzona, Ascona i servizi, anche con il Servizio informazioni militari italiano SIM, fornirono un supporto operativo indispensabile alla Resistenza, scambiando notizie, finanziando attività, fornendo armi e munizioni. Molti documenti e vicende ricostruite declinano le concrete modalità di collaborazione con le formazioni partigiane e le coraggiose reti di solidarietà che salvarono molte vite; tra queste l’impegno coraggioso della Chiesa cattolica con nunzi apostolici, parroci e volontari. Nel libro ho inserito documenti inediti, attinti ad archivi italiani e svizzeri; testimonianze e immagini, note e riferimenti bibliografici».

La tua è una narrazione approfondita e, insieme, un’investigazione storica con approccio giuridico, che evidenziano il contributo attivo della Svizzera alla Liberazione dell’Italia
«La Resistenza è stata quella armata, quella militante e prepolitica, quella del mondo cattolico, quella silenziosa e efficace della popolazione a sostegno. Ma non solo. La Resistenza è stata anche quella degli Alleati inglesi e americani che la sostennero con le loro missioni paracadutate. E quella delle città e dei paesi dei Cantoni elvetici che ospitarono, motivarono e organizzarono l’offensiva resistenziale».
La Svizzera è stato riparo o punto di riferimento di molti italiani…
«Dagli anni ’30 al 1945, la Svizzera è stato il polmone culturale e di conoscenza che ha dato, agli antifascisti italiani espatriati o collegati, le speranze e le motivazioni per battere il nazifascismo. In Svizzera vi erano Fernando Schiavetti, Guglielmo Ferrero, Luigi Einaudi, Francesco Carnelutti, Giorgio Del Vecchio, Alfredo Scaglioni, Alessandro Levi, Amintore Fanfani, Mario Fubini. Concetto Marchesi. E poi alcuni professori dell’università di Ginevra e del Politecnico; altri docenti nei campi universitari di giovani rifugiati ed ospiti del governo elvetico. Vennero create le colonie libere simili alle italiane società di mutuo soccorso: ne facevano parte Piero Malvestiti ed Edoardo Clerici, Adriano Bianchi, Ernesto Rossi, lo scrittore e leader socialista Ignazio Silone a Zurigo, Carlo Sforza, Egidio Reale, Adriano Olivetti, Giorgio Fuà, Luciano Foa, Guglielmo Usellini, Dante Isella e Piero Chiara fra gli internati. E poi Franco Fortini, ebreo fuggito dall’Italia».
Qual è stato il focus di questa tua ultima ricerca?
«Nella ricerca ho indagato e penso di avere, pur sinteticamente, rappresentato, la genesi e la caratterizzazione delle varie Resistenze italiane lungo i 744 chilometri di confine con la Svizzera: dalla Valle d’Aosta alla Valsesia, dalla Val d’Ossola alla Val Grande, dal Varesotto alla Valtellina, dal Comasco al Lecchese fino alla Val Camonica. Resistenze ben diverse, perché erano differenti i contesti sociali ed economici, culturali e di conformazione del territorio; le peculiarità delle relazioni con i grandi centri come Aosta, Torino, Varese, Milano, Como, Lecco, Bergamo, Brescia; le comunicazioni viarie e ferroviarie, i valici e passi fino al confine.
Sul versante svizzero, invece, vi sono state molte e diverse collaborazioni con la nostra Resistenza: ospitalità per antifascisti e poi partigiani; connessioni fra i comandi OSS e SOE e il Comitato Liberazione Alta Italia CLNAI, e le formazioni partigiane; aiuti diretti fra esercito e servizi elvetici e formazioni italiane; sostegno della stampa svizzera per la battaglia italiana per la libertà. Abbondanti prove si hanno oggi consultando molti report inediti attinti al Fondo di Aldobrando Medici Tornaquinci presso l’Istituto Storico Resistenza di Firenze, al Fondo Dugoni presso la Fondazione Filippo Turati, all’Archivio di Stato del Canton Ticino e Bellinzona, all’Archivio Fondazione Pellegrini-Canevascini di Bellinzona».

Quali sono le rivelazioni principali e inedite?
«Innanzitutto il ruolo determinante del nunzio apostolico a Berna Filippo Bernardini e di altri vescovi per ospitare e sostenere i fuoriusciti e i partigiani italiani. Non solo, fra Bernardini e la Santa Sede vi fu una rete riservata di contatti e iniziative, utilissima per salvare molti ebrei e verso la Liberazione del 1945. Attingendo agli archivi vaticani, si scopre ad esempio come, a novembre 1943, il cardinal Maglione scrisse al nunzio Bernardini con incarico di richiedere al Governo elvetico di ampliare le autorizzazioni ad accogliere gli ebrei in fuga dall’Italia.
Altro elemento rilevante è aver trovato, nel Fondo Tornaquinci, le conferme di come il ministro Aldobrando Medici Tornaquinci si attivò per far riconoscere i partigiani garibaldini rifugiati in Svizzera come rifugiati militari e non ribelli.
Terzo punto di rilievo, la presenza In Svizzera di Carlo e Marella Caracciolo nella residenza di Castagnola, come ricorda la partigiana Antonietta Chiovini. Non solo. A ridosso del confine, con attività partigiana, anche Eugenio Cefis, Enrico Mattei, Gianfranco Contini, Gianni Brera. Non solo. Quali stretti collaboratori della Resistenza vi erano le figure di Guglielmo Canavescini, Piero Pellegrini, giornalisti e direttori di Libera Stampa; vi era il capitano dell’esercito Guido Bustelli, ufficiale militare dei servizi elvetici, che coordinò vari militari elvetici nel sostegno alle formazioni partigiane di confine. Figure rappresentative e perno di molte attività a sostegno dell’antifascismo e Resistenza italiana.
C’è un inserto nel libro
«Sì, il testo è accompagnato da un inserto di documenti e immagini, nonché da un QR Code con incluse raccolte più ampie di documenti e immagini».
Sergio, tu sei un avvocato che continua a esercitare, penso al processo tuttora in corso alle Brigate Rosse che agirono alla Cascina Spiotta nel 1975 in provincia di Alessandria. Cosa ti affascina della ricerca storica, la tua seconda attività?
«La ricerca storica è fatica, è capacità di indagine, è pazienza, è competenza metodologica, è onestà intellettuale, è passione verso la verità. Senza una rigorosa e preliminare ricerca documentale archivistica, coltivata scoprendo inediti, atti desecretati, note, epistolari, diari, relazioni riservate, memorie e testimonianze, non si ricostruiscono vicende e protagonisti. La crescente rilevanza degli archivi documentali e storici è confermata dalle molte risorse e impegni organizzativi, con nuove tecnologie, che soggetti istituzionali e privati assicurano».
Gli archivi non sono tutto, giusto?
«All’abbondante ricognizione archivistica e documentale, va abbinata la capacità di integrare, confrontare e verificare la veridicità di alcune fonti con le altre. La ricerca storica non è esercizio accademico o coltivazione di un solo indirizzo dominante o di scuola, è apertura verso le novità, verso il non noto o il contributo diverso e aggiuntivo di altri. È una trama composita, di tanti fili e nodi. Una matrice di lavoro che si pone in parallelo con le tecniche investigative e difensive proprie del diritto penale sostanziale e processuale. Per cercare la verità, le responsabilità, le condotte rilevanti e punibili, il Pubblico ministero, l’avvocato, il giudice devono raccogliere, ricostruire, analizzare un ampio compendio probatorio, non una singola fonte anche se autorevole. La compresenza e l’integrazione di più indizi, documenti, fonti, precedenti giurisprudenziali, prove scientifiche costituiranno le argomentazioni ricostruttive dei rinvii a giudizio, delle difese e delle sentenze. Anche qui, vengono prima le conoscenze dei fatti e delle condotte, poi l’intelligenza critica per declinare moventi e condizionamenti, aggravanti o diminuenti. Ricordiamo, fra i molti, gli approcci giuridici mutuati e coltivati dagli storici Carlo Arturo Jemolo, Giorgio Agosti e Paolo Borgna. Anche questo mio ultimo libro si colloca in questo ambito di ricerca e metodo».
Articolo pubblicato anche su https://www.allonsanfan.it/
Tutte le foto sono tratte dal libro “Non solo neutralità” – Mursia Editore